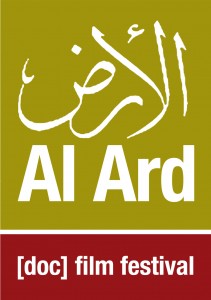Intervista a Mahmud Darwish
di Geraldina Colotti
su Il Manifesto del 29/05/2007
Mahmud Darwish ci parla della tragica situazione della sua gente, a cui un mondo «annoiato» che non produce che «odio» ha voltato le spalle lasciandola sola
«Noi palestinesi siamo entrati in una fase assurda: l’assurdità dei soldati che in battaglia si ammazzano fra loro. Un’assurdità fatale. I significati ci sfuggono, la strada ci sfugge, la nostra stessa immagine ci sfugge». Così il grande poeta palestinese Mahmud Darwish torna a parlare del suo popolo con il manifesto.
La cornice è quella postmoderna e spaesante dell’Hotel Santo Stefano a Torino, eredità delle ultime Olimpiadi, dove Darwish arriva, accompagnato dalla traduttrice libanese Chirine Haidar. Darwish, ospite dell’associazione Circolo dei Lettori, è venuto a presentare il suo libro Oltre l’ultimo cielo. La Palestina come metafora, tradotto da Gaia Amaducci, Elisabetta Bartuli e Maria Nadotti, e pubblicato dalla casa editrice Epoché. Un volume di riflessioni (dal ’96 al 2004), in forma di incontri e dialoghi con diversi intellettuali arabi, che ricapitolano l’itinerario culturale e politico del poeta.
In un capitolo del libro, datato Ramallah ’96, lei dice: «Il nostro presente non si risolve né a iniziare né a finire». E oggi? A che punto è il presente dei palestinesi?
Dopo una fase intermedia, sospesa tra il movimento di liberazione nazionale e la promessa di uno Stato che non si è realizzata, siamo rimasti fermi nel campo del quasi: abbiamo quasi un’autorità , quasi un ministero, quasi un’occupazione… e nello stesso tempo non abbiamo niente. Le ragioni di fondo di quel che sta accadendo oggi, sono senz’altro politiche: un intero popolo si trova in un carcere e i carcerieri quando c’è grande tensione guardano i prigionieri che iniziano a lottare fra di loro e giocano con le loro differenze, con i loro limiti. A Gaza c’è fame, e l’uomo armato quando ha fame diventa un mercenario, riversando sul popolo anche problemi morali. Ma c’è anche qualcosa di profondo e di non risolto, che va oltre le differenze di linee politiche interne, e spinge i fratelli a combattersi fra loro anziché combattere l’occupazione. Ci siamo resi conto che gli accordi di Oslo hanno scavato un baratro in cui siamo caduti, ma non abbiamo ancora realizzato appieno quale sia la nostra posizione attuale, fino a che punto abbia giocato nel profondo la frustrazione provocata da Israele, sordo a ogni nostro tentativo: Israele firma gli accordi, e poi non li rispetta. Vuole il muro di separazione, e il muro viene costruito, eppure la pace continua a rimanere lettera morta, persino quando tutti i paesi arabi si mobilitano per normalizzare le relazioni. E intanto, nel mondo è cambiata l’immagine del palestinese: prima era un partigiano della libertà , oggi i media nordamericani e israeliani gli hanno costruito l’abito del terrorista, una maschera che gli viene sbattuta in faccia e in cui deve riconoscersi. Il mondo intero, però, ha dimenticato il problema fondamentale: c’è un popolo che vive sotto occupazione da 40 anni, e che non sta chiedendo niente di strano, solo il 22% del suo territorio storico. Ma il mondo è annoiato e non si cura di quanto noi, esseri circondati e assediati, possiamo essere sfiniti, di quanto possano malamente implodere le energie frustrate e latenti da 12 anni. Il mondo intero produce odio, ma non vuole accusare Israele per timore di essere accusato di antisemitismo. Così Israele anziché uno Stato che opprime, diventa un valore etico, al di là di ogni legge: non più un fenomeno storico, ma divino. E Peres, che passa per uomo di pace, può dire tranquillamente che le colonie sono soltanto blocchi residenziali israeliani. Il linguaggio politico è categoricamente cambiato secondo la volontà israeliana, l’occupazione è ormai parola impronunciabile e incomprensibile…
Nel corso degli anni, i suoi versi sono stati quelli del «poeta veggente», capaci di anticipare le fiamme di Beirut e il calvario dei profughi senza diritto al ritorno. Pensa che Beirut stia per esplodere ancora?
Sono stato a Beirut un mese fa, ho partecipato alla Fiera del libro arabo con le mie poesie, ma non sono riuscito a riconoscere la città . Sì, il mare c’era, la montagna c’era, la gente anche, però mi è sembrato di leggere nei loro sguardi una specie di scissione tra la paura di vedere realizzate le previsioni più nere e la volontà di non volere più assomigliare a qualcun altro. Purtroppo, dalle nostre parti, le questioni interne sono punti su un’agenda esterna, non abbiamo neanche il diritto di scrivere un ordine del giorno. La situazione regionale dipende da quella internazionale, nessuno è libero, nessuno è indipendente, meno che mai i palestinesi. Il diritto al ritorno, ormai, è parola proibita nel registro israeliano, ma anche in quello di alcuni regimi arabi e in quello internazionale, perché – si dice – rappresenterebbe un pericolo per lo Stato di Israele. Intanto i profughi sono sempre più numerosi e la loro situazione peggiora. Il diritto al ritorno, però, sembra diritto esclusivo della diaspora israeliana, che lo attende da 2.000 anni. A quelli cacciati solo da 50-60 anni resta solo il diritto a… emigrare. E intanto, ogni anno, se vado nei campi o accendo la televisione, vedo sempre la stessa immagine: una donna palestinese che porta via le sue cose e i suoi bambini, che sta scappando in un campo di Rafah, di Gaza o del Libano. La vedo gridare, alzare le mani al cielo, ma il cielo non risponde. Questa donna una volta era mia madre, poi è stata mia sorella e forse adesso è mia figlia.
A lei è toccato di esplorare il limite, frequentando la morte, l’esodo o il carcere. Cosa apporta al poeta un’esperienza simile?
La vera poesia è una particolarissima miscela chimica che filtra l’esperienza collettiva attraverso quella intima. La poesia richiede e offre metafore per rendere la realtà più sopportabile. Quando ero in carcere, da un punto di vista poetico vedevo il mio carnefice come un prigioniero, e mi sentivo più libero di lui perché io ero soltanto privato della libertà , ma non della capacità di riconoscere l’altro dentro di me. Non ho cambiato opinione. Il nemico ha numerose maschere, abbiamo tratti in comune e, in queste condizioni umane complesse, può capitare di scambiarsi i ruoli. Ma io non voglio abitare l’immagine che il nemico ha scelto per me. Io ho scelto il campo dei perdenti, mi sento un poeta troiano, uno di quelli a cui è stato tolto persino il diritto di tramandare la propria disfatta.